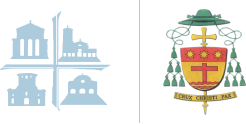Assemblea diocesana di fine anno pastorale
Venerdì 14 giugno 2024
“La nostra Chiesa in cammino sinodale: le Unità di collaborazione tra parrocchie”
Introduzione ai lavori
+ Mariano Crociata
Dopo aver rivolto uno sguardo all’anno pastorale trascorso portiamo ora l’attenzione sull’anno prossimo. Esso ci si presenta già segnato da tre ambiti di impegno. Il primo è dettato dalla ricorrenza giubilare: il calendario, la prassi ormai plurisecolare della Chiesa e, non ultimo, l’invito del Papa ce lo chiedono, senza dimenticare che il giubileo è comunque un’occasione irripetibile di grazia e di rinnovamento. Il secondo è il progetto che stiamo portando avanti da qualche anno, e cioè il Percorso dell’Iniziazione Cristiana. Il terzo ambito di impegno è quello su cui vorrei che riflettessimo insieme in questa assemblea diocesana.
Come avete visto dalla locandina, parliamo delle Unità di collaborazione tra parrocchie e di cui ho parlato in questi mesi con preti e diaconi incontrandoli nelle riunioni delle foranie. Il nome è funzionale e descrittivo. “Unità” in questo caso è un concetto operativo, sociologico, non teologico. Intende semplicemente designare un gruppo di parrocchie. “Collaborazione” è l’attività concreta proposta, l’indicazione specifica diretta a promuovere il lavorare insieme in alcuni settori. Le “parrocchie” sono la figura ecclesiale e anche giuridica che conosciamo e che non deve certo venire stravolta né da questa né da altre proposte.
Da che cosa nasce questo nuovo progetto pastorale pensato per integrare e rafforzare il nostro cammino di Chiesa diocesana? Concretamente esso è il risultato che ho raccolto ed elaborato dalle tante riflessioni svolte in questi anni in sede di Consiglio pastorale diocesano e di Consiglio presbiterale in prospettiva sinodale. L’esigenza di stile sinodale, che papa Francesco ha lanciato come orientamento per la Chiesa del futuro e che anche la Chiesa Italiana ha raccolto prontamente, interpreta la vocazione propria della Chiesa che il Concilio ha riscoperto, e cioè quella di una Chiesa sempre più unita da una sensibilità comune e da una capacità di operare coinvolgendo tutte le sue componenti e tutti i suoi membri in una prospettiva missionaria. Il camminare insieme che la parola sinodo significa e chiede è l’unico modo adeguato di essere Chiesa oggi.
Perché le Unità di collaborazione tra parrocchie sono il nostro modo di camminare insieme, di diventare Chiesa sinodale? La risposta appare evidente interpretando la situazione pastorale attuale con l’aiuto di due categorie conciliari. Le categorie sono quelle di “popolo di Dio” e di “comunione”. La prima è il tema e il titolo del secondo capitolo della costituzione conciliare sulla Chiesa Lumen gentium, la seconda è adottata dal Sinodo dei Vescovi del 1985 per interpretare sinteticamente e definire la caratteristica peculiare dell’ecclesiologia conciliare. “Comunione” e “Popolo di Dio” sono categorie portanti generate dalla fede cristiana sulla Chiesa, avendo entrambe le loro radici nel Nuovo Testamento, e determinanti per esprimere la comprensione che essa ha di sé a partire dal suo essere generata dal Risorto nella potenza del suo Spirito.
In che modo popolo di Dio e comunione interpretano e illuminano propriamente la nostra attuale situazione pastorale? Provo a dirlo in maniera sintetica: la struttura tridentina che caratterizza ancora oggi la parrocchia, con la configurazione giuridica canonica che le è propria, non la aiuta a progredire nella direzione di una comunità in comunione, quale dovrebbe diventare particolarmente in un contesto storico e sociale di fine della cristianità.
Solo l’immagine di una Chiesa che rispecchi la volontà di Cristo su di essa ed esprima il suo orientamento missionario è all’altezza del nostro tempo, perché è l’unico modo di essere la Chiesa di sempre nella sua attuazione in questo tempo e nella nostra condizione umana e sociale. Una Chiesa che non si presenti come un gruppo di credenti che si vogliono bene, che fanno unità, che lavorano insieme e vivono in comunione non è in grado di far parlare Cristo e quindi di svolgere alcuna missione cristiana. Provo a spiegare.
La struttura attuale della parrocchia ha una configurazione adatta ad una società anche solo in maggioranza cristiana, e quindi plasmata da una mentalità cristiana dominante, e non solo per le statistiche sulle richieste di battesimi. Oggi, la mentalità dominante è tutto fuorché cristiana anche se molti chiedono ancora i sacramenti. La cura che la sacramentalizzazione richiede ha l’effetto di mantenere attiva una dimensione religiosa, certo di impronta cristiana, soprattutto rilevante per la vita privata di tante persone che si limitano a chiedere e celebrare i riti cristiani nei momenti sempre importanti per la vita umana, dal nascere al morire, dal crescere allo sposare, ai quali tuttavia non segue per lo più nulla dell’esistenza cristiana ecclesiale.
Questo significa che la parrocchia è così assorbita da questo compito, oltre che oberata da altri meccanismi e appesantita da consuetudini e retaggi, da trovare difficile coltivare convenientemente la dimensione comunitaria della parrocchia e svolgere il suo compito missionario. Nel nostro linguaggio ordinario usiamo in maniera interscambiabile i termini parrocchia e comunità parrocchiale, ma nella gran parte dei casi le parrocchie non sono e fanno fatica a diventare comunità, essendo esse soprattutto strutture ecclesiastiche dedicate a servizi religiosi, certo non privi di nuclei di relazioni significative ed esemplari, che per lo più però ruotano attorno e si esauriscono nell’assolvimento dei compiti richiesti dai servizi religiosi.
Quando esisteva la cristianità, la comunità parrocchiale (termine non certo adottato in passato) coincideva con la totalità, o almeno la grande maggioranza, dei fedeli del territorio parrocchiale, i quali non solo praticavano i riti in chiesa, ma ritmavano la loro vita privata, familiare e sociale secondo lo spirito e il senso cristiano della vita. La chiesa con il parroco era il centro dei servizi religiosi che permettevano alla comunità dei fedeli di essere veramente tale nel proprio insediamento territoriale e nel proprio ritmo di vita. E la vita era plasmata dalla fede. Oggi abbiamo ridotto la parrocchia a sinonimo di chiesa-edificio, al parroco e ai suoi collaboratori, finendo con il chiamare questo la comunità. È vero che ci sono pur sempre tutti i fedeli battezzati, ma questi spesso si riducono a fantasmi che ogni tanto si materializzano.
Non dimentico naturalmente la ben nota rappresentazione articolata che distribuisce in tre raggruppamenti i fedeli che fanno riferimento alla parrocchia, e cioè la fascia ministeriale (i collaboratori assidui), la fascia eucaristica (i cristiani della domenica) e la fascia battesimale (tutti gli altri). Proprio questa differenziazione ci conferma che la comunità non ha più una precisa figura umana e sociale. Per completezza e onestà intellettuale bisogna aggiungere che non mancano parrocchie in cui il senso comunitario è forte all’interno dei gruppi, vuoi di tipo associativo, vuoi di servizio, e anche oltre, ma spesso la conferma di una divaricazione tra parrocchia e comunità la troviamo nel fatto che la comunione tra i gruppi (e, ahimè, spesso anche tra le persone) è di là da venire.
Non bisogna dimenticare che questa figura di parrocchia, erede di una lunga e grandiosa storia, custodisce un pregio di raro valore, in quanto essa è il segno che la Chiesa è aperta a tutti. Se c’è una cosa che definisce l’essenza della Chiesa è che essa non è chiusa a nessuno, accoglie tutti, ovviamente sempre alle condizioni che la fede richiede. La parrocchia protegge dalla tentazione di fare della comunità cristiana una setta, e so bene che non mancano di quelli che provano a stabilire dinamismi possessivi, escludenti e perfino di tipo settario.
Quello che voglio dire, allora, è che bisogna operare in due direzioni, e cioè verso la capacità di accogliere i praticanti per “convenzione” (cioè per abitudine mentale personale e sociale) e, nello stesso tempo, procedere nello sforzo di aprirsi a quelli che non sono interessati a pratiche religiose, ma portano dentro motivi di ricerca, inquietudini, sensibilità che hanno bisogno di essere accostati e accolti fuori dagli schemi dei servizi religiosi forniti dalle parrocchie, così da trovare modalità nuove di incontro e di dialogo. Questa è la missione oggi, naturalmente rivolta anche ai praticanti per convenzione. Del resto, non ci vuole molto a rendersi conto della fatica che facciamo con i ragazzi e i giovani, che sono quanto meno insofferenti, se non indifferenti, ai nostri riti. E si capisce, dal momento che la Messa dovrebbe essere il punto di arrivo di un cammino personale ed ecclesiale, e invece noi ne facciamo il primo obbligo chiesto indifferentemente a tutti. Si direbbe che sappiamo offrire solo Messe (senza nulla togliere ad essa, naturalmente!).
Le Unità di collaborazione tra parrocchie non sono il toccasana, la soluzione di tutti i problemi. Sono semplicemente un indicatore di direzione: cercare di superare la rigidità dello schema di azione pastorale della parrocchia tridentina per farla aprire alla collaborazione nel segno della relazione. La collaborazione a cui faccio riferimento significa aprirsi ad altri e stabilire nuove relazioni, e da lì cominciare a far nascere nuovo senso di comunità, sia per i praticanti tradizionali che per i nuovi cercatori di Dio. Essa non è la bacchetta magica che fa nascere la comunità, ma indica la pista obbligata per andare nella sua direzione, e cioè aprirsi, superare i circoli chiusi, i gruppi fissi, il monopolio dei servizi e delle collaborazioni, la chiusura verso il nuovo e verso i nuovi.
Perché e in che modo l’Unità di collaborazione tra parrocchie contribuisce a trasformare la parrocchia in comunità? Diventare comunità in comunione è innanzitutto dono di Dio, poiché è solo da Lui che viene la grazia con cui il Cristo risorto nella potenza dello Spirito riconcilia i peccatori, li rende figli e li unisce a sé formando il suo Corpo che è la Chiesa. Ma tale dono diventa riconoscibile e trasformante là dove incontra accoglienza e corrispondenza nella fede e nella vita dei credenti. Questo si compie in tanti modi, ma tutti hanno questo di caratteristico: uscire da sé per andare verso Dio e verso i fratelli. Proprio ciò di cui c’è più bisogno oggi: ritrovare la gioia e l’entusiasmo della fede in un rinnovato incontro con il Signore e nella condivisione con altri.
Le nostre comunità troppo spesso appaiono stanche e rassegnate. Ma questo è il contrario dell’esperienza che nasce dall’ascolto del Vangelo e dall’incontro con Gesù. Per questo bisogna rompere gli schemi che ci tengono imprigionati. Si tratta di chiusure che sono soprattutto dentro di noi, ma possono essere smantellate se ci apriamo e andiamo incontro agli altri. Le Unità di collaborazione tra parrocchie sono l’invito e l’occasione per avviare questo movimento vitale e vitalizzante del rinnovo delle relazioni nel nome di Gesù e del servizio alla Chiesa nell’aiuto prestato tra le comunità. Dobbiamo aiutarci soprattutto a crescere nella fede intesa come esperienza viva e trasformante che rende i credenti comunità in comunione, perché con essa imparano a vivere volendosi bene e trasmettendo così la bellezza e il fascino della vita con il Signore.
In concreto si tratta di costituire reti stabili o semplicemente gruppi di parrocchie il più possibile contigue nel territorio perché tra di esse si cominci ad aiutarsi a promuovere una pastorale più ricca e completa. Ci sono parrocchie che hanno tutto e altre che hanno meno, sia come collaboratori sia come fedeli sia come iniziative pastorali per i propri parrocchiani. Si tratta di far sì che ogni parrocchia diventi più viva con l’aiuto delle altre e prestando aiuto alle altre, perché tutte esse hanno qualcosa da dare e non solo da ricevere.
Non partiamo da modelli precostituiti e tanto meno da obblighi circa gli ambiti e le modalità secondo cui agire, perché c’è bisogno che i parroci e i collaboratori valutino la situazione e concordino su quali ambiti cominciare ad agire. Ho suggerito come esemplificativi alcuni ambiti che ho indicato nei seguenti:
- Scuola ed esperienze di spiritualità
- Pastorale giovanile e vocazionale
- Caritas
- Famiglie e coppie
- Programmazione catechesi dei ragazzi e degli adulti
- Accompagnamento e formazione di catechisti, educatori e animatori
- Attività estive per ragazzi, giovani e adulti
Ma è la situazione concreta che deve dettare le scelte e l’agenda di ogni singola Unità. A questo scopo sarà necessario uno sforzo di accompagnamento, per il tramite di un parroco di riferimento in ogni Unità di collaborazione, sempre che non sorgano altre forme e modalità. In prospettiva questa impostazione dovrebbe portare come frutto un alleggerimento del peso sulla singola parrocchia e una crescita della qualità delle relazioni e delle attività per effetto del coinvolgimento più vasto di persone e di collaborazioni.
Lo scopo del lavoro dei gruppi di questa assemblea è far riflettere tutti su questo tema a partire ciascuno dalla propria esperienza. Non si tratta di elaborare teorie o immaginare scenari di chissà quale genere, ma di far crescere l’esperienza di presenza e di collaborazione nelle parrocchie allargandola alle parrocchie vicine. E questo in maniera condivisa, ordinata e sistematica.