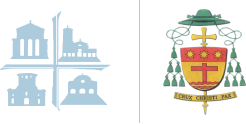Oggi pomeriggio, nella cattedrale di San Marco a Latina, don Giovanni Grossi, 28 anni d’età, è stato ordinato sacerdote per l’imposizione delle mani del vescovo Mariano Crociata. A concelebrare tanti altri sacerdoti e diaocni pontini. Domani, il novello sacerdote, presiederà per la prima volta la Santa Messa nella concattedrale di San Cesareo a Terracina.
Di seguito l’omelia pronunciata dal vescovo Mariano Crociata:
OMELIA
Domenica 1 ottobre 2017 XXVI TO A, Cattedrale di S. Marco
Ordinazione presbiterale di Giovanni Grossi
+ Mariano Crociata
Alle spalle di una ordinazione presbiterale c’è sempre un lungo percorso di discernimento e di formazione, che rimanda alla visione d’insieme del sacerdozio cattolico, imponente e impressionante per la memoria di dedizione e di santità che rievoca. Eppure questo insieme grandioso in cui si condensa una grande storia, si raccoglie e rivive in ogni attimo e in ogni prete, allo stesso modo come tutte le grandi costruzioni vengono su una pietra dopo l’altra. Anche questo momento – forse soprattutto un momento come questo – ha il potere di racchiudere il tutto, del passato, e di rilanciarlo nel futuro.
L’ordinazione segna il passaggio sacramentale a una nuova identità ministeriale, frutto di una specifica grazia divina e di una distinta responsabilità nelle relazioni con i fratelli di fede, nella Chiesa. Essere prete significa servire il Signore, supremo pastore, aiutando i fratelli a camminare sotto la sua guida. Parola ed esempio di vita, sacramenti e preghiera, dialogo e decisioni: sono questi i principali strumenti di una collaborazione sacramentale che ha nel Signore Gesù il riferimento ultimo e nel Vescovo e nel presbiterio, uniti, il tramite del discernimento che continuamente conferma se il singolo prete sta edificando veramente la Chiesa di Dio e non, invece, se stesso. Vescovo e presbiterio devono rimanere sempre radicati nell’unità della comunione e della dedizione condivisa alla missione della Chiesa, nello sforzo di perseguire insieme il cammino e gli obiettivi che essa si dà.
Il tutto si compie sotto l’ascolto della Parola di Dio, e in modo particolare del Vangelo. Il quale non può essere sezionato, quasi che solo alcune sue parti riguardino i preti. Tutto il Vangelo parla a tutti, ha qualcosa da dire a ciascuno. Come la pagina di oggi, con i due fratelli della parabola nessuno dei quali è esemplare. Se è vero che ci indispone la doppiezza, la falsità, l’ipocrisia del figlio che risponde di sì ma poi non si fa scrupolo di andarsene per i fatti suoi, senza dignità per la parola data e non mantenuta, infedele con il cuore e con la vita, non possiamo certo prendere a modello il secondo figlio, che non è capace di dare corrispondenza con i fatti ai suoi sentimenti e alla sua parola. Sono due figli diversamente infedeli. Non c’è un terzo figlio, che dica sì e faccia sì: solo Gesù è il Figlio beneamato, e solo in Lui anche noi possiamo essere accolti come figli. Sembra un giudizio sulla nostra condizione di uomini e di credenti: inutile andare a cercarne uno perfetto. Le situazioni sono di uno scuro dalle diverse sfumature, ma non si trova l’inequivocabilmente chiaro.
Questo ci porta a capire che gli atteggiamenti dei due figli non sono soltanto fuori di noi, oggettivati in due distinte persone. Sono invece dentro di noi, che portiamo nel cuore la tentazione di fare finta, di apparire a posto, ligi al dovere, disponibili alle richieste di chi ha il diritto di rivolgerle, salvo portare dentro e poi mandare anche ad effetto il rifiuto, la chiusura, il menefreghismo; oppure, all’opposto, la tentazione della ribellione, dell’insofferenza, dell’evasione dagli impegni e dalle responsabilità. La verità è che siamo divisi dentro, che i due figli sono ambedue dentro di noi, dilaniati come siamo tra la tendenza ad apparire o alla ribellione e il richiamo della responsabilità e del dovere. Il giudizio del Vangelo è netto: la colpa di chi dice sì solo a parole è più grave, soprattutto se il rifiuto del secondo viene corretto dal ripensamento e dal pentimento.
Caro Giovanni, nella lacerazione interiore che tutti ci affligge, la prima tentazione è quella specifica di noi preti. Noi siamo quelli che diciamo sempre sì, perché stiamo sempre sull’altare, a celebrare e a fare le prediche agli altri, a compiere atti religiosi e occuparci ex professo di Dio, dei santi, delle cose sacre. Ma bisogna che a quel sì delle parole e delle forme religiose segua il sì dei fatti, della vita. Per questo abbiamo bisogno di imparare sempre di nuovo a ripensare la nostra vita, a ricrederci, a pentirci, a correggerci. C’è qualcosa di peggio di sbagliare e commettere errori: è precisamente il non riconoscerlo e il non ammetterlo, il non volersi ricredere e il non voler rimediare.
Non solo il Signore, ma anche i nostri fedeli non si aspettano da noi che siamo perfetti, ma che siamo umili (abbiamo proprio ora ascoltato l’inno cristologico di Filippesi) e disponibili a cambiare quando ce n’è motivo. Ciò che è insopportabile, anche agli occhi di Dio, è la presunzione, l’arroganza, l’improntitudine. «Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». Quante cose abbiamo visto noi e quante ne vediamo continuamente: quanto Vangelo, quante omelie, quante preghiere, quante liturgie e così via! Ma dov’è il nostro pentimento per credere. Mi piace il gioco di parole che dice: per credere bisogna imparare a ricredersi. La fede non si scrive come una bella parola su una lavagna pulita, ma ha bisogno di scontrarsi con una infinità di parole tra le quali farsi strada. Su tante, troppe cose bisogna fare ammenda e purificazione: ricredersi per credere. Questo è chiesto ad ogni credente, e proprio per tale ragione è chiesta in primo luogo a noi preti. Altrimenti, al di là delle illusorie apparenze di credito personale o di ruolo, saremo passati avanti da tanti che ritenevamo esclusi, perché a tutti è data la possibilità di pentirsi, come dice Ezechiele. E ciò che conta per Dio non è avere preti, ma persone che credono perché si ricredono e si pentono.
Il nostro essere persone che si ricredono e si pentono, allora, renderà prezioso e vero il nostro ministero, perché sapremo aiutare i nostri fratelli a pentirsi a loro volta, a cambiare registro e orientamento alla loro vita.
Caro Giovanni, il tuo ministero sia segnato dalla fedeltà stabile e serena al Signore e alla Chiesa, senza inutili agitazioni e senza irragionevoli timori, semmai con la sana inquietudine di chi sa di non essere mai abbastanza adempiente con il Signore. Cura la ricerca di quell’unità interiore senza la quale è difficile ogni altra unità, con il Signore, nel presbiterio, con il Vescovo, con i fedeli. Te lo auguro di cuore, insieme a tutta questa bella assemblea, che, certo, non cesserà di pregare per te.