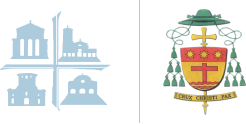La perdita dalla prospettiva spirituale
Latina, 01/02/2021 – Convegno del Consultorio diocesano familiare “Crescere Insieme”
✠ Mariano Crociata
Ho inteso la richiesta di una riflessione sul tema così formulato (La perdita dalla prospettiva spirituale) come il segnale di un’esigenza: collocare in un orizzonte più vasto l’esperienza della perdita e le forme e gli strumenti per affrontarla. Questo orizzonte viene definito spirituale, qualifica che per noi ha un significato specificamente cristiano. L’invito sotteso al titolo è il seguente: prima di prenderci cura (o anche mentre ci prendiamo cura) di chi ha subito lutti e di chi sta soffrendo deprivazioni e disagi materiali o psicologici per effetto della pandemia, cerchiamo di capire che cosa l’esperienza della perdita significa e quale luce chiede alla fede, quale orientamento ne può ricevere.
La perdita della quale parliamo è quella della morte di una persona cara o vicina o conosciuta, ma sappiamo che questa è la forma estrema di una esperienza di perdita che assume una varietà di forme, come la perdita del lavoro, della sicurezza economica, della stabilità dei rapporti familiari o amicali, della serenità interiore o perfino dell’equilibrio psicologico personale, di opportunità di vita su cui si puntava e andate in fumo, non ultimo della salute. Se la nostra attenzione si concentra sul lutto, non vuol dire che dimentichiamo che ci sono altre forme e gradi di esperienza di perdita.
Volendo andare subito al punto, per cogliere il senso spirituale della perdita dobbiamo guardare a Gesù e a ciò che la Scrittura ci trasmette, insieme alla tradizione ecclesiale. Prima di entrare nel merito, però, mi pare necessario riportare una osservazione che non sono pochi oggi a proporre. Se guardiamo al contesto culturale nel quale siamo immersi, soprattutto nei Paesi occidentali, non facciamo fatica a vederlo caratterizzato da una marcata sensibilità verso i diritti individuali, che talora giunge fino a una vera e propria loro assolutizzazione (è di questi giorni l’approvazione del cosiddetto “Rapporto Matic” da parte dell’Europarlamento, che tra l’altro prevede il riconoscimento dell’aborto come “diritto umano”). Tale caratterizzazione culturale dominante rende di difficile accettazione e gestione qualsiasi tipo di perdita. Piuttosto che cercare il senso della perdita, e prima ancora di attivare processi adeguati di elaborazione psicologica e sociale, ciò di cui si va alla ricerca è innanzitutto il colpevole e di chi sono le responsabilità. In un simile clima culturale diventa difficile dare un senso e fare i conti con perdite di cui non sia possibile ricostruire evidente eziologia e facile spiegazione.
Ma diventa difficile anche sciogliere il paradosso della grande attenzione portata sul tema della morte, con una sua vera e propria ricerca quando si tratta di fine vita ed eutanasia, e la sua sostanziale censura o la sua medicalizzazione o ancora la sua proceduralizzazione. In realtà proprio il cercare un senso, unitamente ai vari processi di elaborazione del lutto, ha la possibilità di far recuperare o perfino scoprire un rapporto positivo con la realtà e di valorizzare l’esperienza della perdita in funzione di una ripresa di maggiore qualità dei percorsi di vita personale e sociale. Ma questo richiede una dimestichezza con l’idea della propria morte, anch’essa sconosciuta alla nostra cultura. Come suggerirebbe il poeta inglese John Donne, con tutta la tradizione cristiana: «Ogni morte di uomo mi diminuisce, perché io partecipo dell’umanità: e così non mandare mai a chiedere per chi suona una campana: essa suona per te»[1].
Uno sguardo sommario alla Sacra Scrittura consente di fare un affermazione generale del seguente tenore: la morte è allo stesso tempo quanto di più innaturale e inaccettabile ci sia, ma anche quanto di più inevitabile. Dice il libro della Sapienza (1,13): «Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi». E poco oltre aggiunge (2,24): «Ma per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono». C’è una dinamica interna alla creazione di Dio che ha introdotto qualcosa che è contro il disegno di Dio e a cui solo Lui può porre rimedio. Attorno alla questione della morte, ultima conseguenza del male, ruota il rimedio, cioè il disegno di salvezza di Dio e la sua storia. Perciò san Paolo può proclamare: «l’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte» (1Cor 15,26); sarà annientata, ma all’ultimo. Non c’è modo di sfuggirle finché siamo immersi nel grande fiume della storia.
Come si pone Gesù di fronte alla morte? E quindi, anche, come si pone Dio? La risposta è già data: la sua opposizione è polare; non ci può essere nulla in comune tra Dio e la morte. Dio può solo combatterla e distruggerla. E proprio questo è ciò che vuole. Come si manifesta questa opposizione e che cosa di essa dobbiamo capire e compiere? Guardiamo a Gesù. Egli previene e inganna la morte, la combatte, ne piange le vittime, a cominciare dagli amici, ma soprattutto se ne fa carico in prima persona e diventa lui stesso un ‘perduto’, come sperimentano Maria di Magdala (cf. Gv 20,1-18), le donne, gli apostoli e i discepoli, pensiamo in particolare a quelli di Emmaus (cf. Lc 24,13-35). Da qui possiamo ricavare molto per dare senso all’esperienza della perdita e accompagnarla.
Tutta l’opera di Gesù è una lotta contro il male in tutte le sue forme e contro il maligno. Egli mostra di essere venuto per questo. Attento a tutti i sofferenti, guarisce tutti i malati che può e conforta gli infelici che incontra. Nel suo breve tratto di vita pubblica fa esperienza della morte di persone che gli chiedono aiuto e anche di persone vicine e amiche. Risuscita persone morte, come la figlia del capo della sinagoga, Giairo (cf. Mc 5,22-24. 35-43). Di grande impatto, poi, l’azione di risuscitamento che compie sull’amico Lazzaro (cf. Gv 11,1-44), per il quale si fa notare soprattutto il pianto di Gesù, anche se non bisogna svuotare della sua effettiva profondità una reazione che è, sì, di sincero affetto e di profonda pena per l’amico, ma abbraccia anche il dolore di Messia che soffre nel venire ancora una volta a contatto con la presenza e con gli effetti devastanti del male e del maligno.
Gesù è un uomo di Dio, o meglio l’uomo-Dio, che cerca vita e promuove vita, dovunque e con tutti, senza differenza di religione o di razza, nonostante le prime resistenze che provengono dalla sua appartenenza religiosa, alla quale rimane sempre ligio, in fedeltà alla missione che sente affidatagli dal Padre. E nutre una specie di gelosia divina verso tutti quelli che gli sono stati affidati, a cominciare dai dodici: «Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io» (Gv 17,34); «non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato» (Gv 18,9). Proprio questo attaccamento totale, e potremmo dire viscerale, di Gesù a quelli che gli sono stati affidati dal Padre, che vanno dagli ultimi e poveri che incrocia per le strade della Palestina a quanti si sono messi in un modo o in un altro alla sua sequela, questa dedizione totalizzante ha un effetto che sulle prime rischia di essere occultato dalle dinamiche esteriori che conducono Gesù alla morte. In realtà anche nelle vicende drammatiche degli ultimi giorni Gesù sta sempre dalla parte del Padre e della causa che gli ha affidato, e quindi dalla parte dei suoi, per i quali è disposto a dare tutto se stesso.
Di fatto ciò che avviene a lui non è la consumazione di un destino di morte anonimo o casuale, ma il risultato di una scelta convinta e coerente che porta fino in fondo la sua missione. Fino all’ultimo Gesù rifiuta di difendersi e di farsi difendere, semmai per quanto può difende i suoi e quasi li giustifica. Gesù abbraccia la morte, la sceglie in qualche modo, nonostante tutte le resistenze di una natura umana che cerca sempre e a tutti i costi l’autoconservazione. Gesù, dunque, conosce la spietatezza della morte e la combatte con tutte le forze, fino allo stremo. Lo stesso sottostare ad essa, e anzi l’abbandonarsi ad essa nella volontà del Padre e nella certezza del suo amore vittorioso su tutto, è espressione non di rassegnazione alla morte, ma di resistenza ad essa fin dentro il suo patirla e il suo diventarne vittima. Più che alla morte Gesù si rimette, in realtà, alla volontà del Padre e alla certezza del suo amore.
Qui bisognerebbe svolgere una adeguata digressione che renda ragione di ciò che Dio è e ha voluto. Nella Sacra Scrittura abbiamo un formidabile termine di paragone, il cosiddetto sacrificio di Isacco (cf. Gen 22,1-18), che mostra in verità che Dio non gradisce sacrifici umani e, infatti, sostituisce il figlio di Abramo, Isacco, con un ariete che verrà sacrificato in sua vece. Ciò che non può essere aggirato è che, quando si tratta del suo Figlio, di Gesù, Dio Padre non procura un animale o qualcos’altro per rimpiazzarlo. Dio non risparmia il proprio Figlio (il quale soffre angoscia mortale e chiede implorante di essere risparmiato), e anzi gli chiede di portare avanti fino in fondo la sua missione, fin dentro la morte di croce. Non risparmiando il Figlio, Dio non risparmia se stesso. Il suo amore è così grande che mentre non può permettere che vinca il male e l’umanità rimanga vittima del suo destino di malvagità, nemmeno può accettare che la morte l’abbia vinta in alcun modo, e proprio questo appare nella sua forma contraria, poiché sembra rimanere insensibile al grido del Figlio e quasi non riconosce il volto del Figlio, pur vedendone e accogliendone la donazione perfetta che egli fa di sé alla sua volontà di Padre. Nell’amore che Padre e Figlio si sono in tal modo scambiati, e cioè nello Spirito Santo, è la vita a sprigionare e a vincere ogni male e ogni oscurità. La risurrezione di Gesù è la potenza dell’amore di Dio che esplode dallo scambio d’amore di Padre e Figlio sigillato sulla croce nel dono reciproco dello Spirito.
Dobbiamo con grande celerità andare ora verso le conclusioni. Le quali sono molto semplici. Si tratta infatti di guardare in questa ottica alla propria morte e, insieme ad essa, imparare a guardare alla perdita delle persone care, amiche, vicine, con, dentro, la certezza di fede nel Dio della vita, insegnando anche ad altri a vivere nello stesso stile la perdita dolorosa di qualcuno. C’è un punto, fra tutti, che sovrasta la considerazione della morte tra morte altrui e morte propria, tra dolore proprio e altrui. Come osserva lucidamente lo scrittore C.S. Lewis, «se mi fosse veramente importato, come credevo, dei dolori del mondo non sarei stato travolto dal mio»[2]. Di conseguenza, «non si può mai sapere con quanta convinzione si crede a qualcosa, fino a quando la verità o la falsità di questo qualcosa non diventano questione di vita o di morte»[3].
Ciò che mettono in evidenza quanti si occupano di elaborazione del lutto e di accompagnamento in tale processo, è che ciò a cui deve pervenire chi ha subito la perdita di una persona amata è una visione positiva della vita e della realtà, un modo nuovo di guardare ad essa, una sorta di conversione che rigenera la persona in lutto dall’interno, risvegliando energie sopite e capacità nuove per affrontare la vita, un accesso alla percezione di ciò che è essenziale e alla scelta dell’unico necessario. Tali cambiamenti cominciano con l’apprendimento della capacità di lasciar andare, di rifiutare la tentazione del possesso. Dice un proverbio inglese: «Se ami qualcuno, devi lasciarlo andare. Se ritorna è tuo. Se non ritorna non è mai stato tuo». Questo presenta un formidabile intreccio con la fede, che ancora lo scrittore C.S. Lewis esprime bene rivolgendo questa domanda a Dio: «Potrò ritrovare H. solo se imparerò ad amarti al punto che non mi importerà più se la ritrovo o no?»[4].
Un vero processo di elaborazione del lutto è chiamato a sfociare in un nuovo senso della vita. L’aver compreso il senso del rapporto di Gesù con la morte e del suo stesso morire offre non solo spunti di intelligenza e di scelta nella propria esperienza della perdita, ma ispira il desiderio di percorrere la sua stessa strada, passando dal dolore proprio a un rapporto più profondo con il proprio sé, alla riconciliazione con se stessi, all’apertura al dolore degli altri, fino alla disponibilità a consumarsi per gli altri, alleviarne il dolore e aprire a nuovi orizzonti di vita. Perché nessuno andrà perduto per Dio, e perché nella morte «ogni essere umano viene trasformato totalmente nell’immagine unica che Dio si è fatto di lui. Allora quell’immagine ritorna al suo splendore originario»[5].
Proprio in riferimento a questa prospettiva, che è insieme protologica ed escatologica, mi piace in chiusura sfiorare il tema delle lacrime, del pianto per la perdita di una persona amata. Sempre Lewis, in questo aureo libretto – Diario di un dolore – scritto per elaborare la perdita della moglie, confessa, riprendendo la beatitudine evangelica: «“Beati quelli che piangono” e io l’avevo accettato. Non ho nulla che non fosse nei patti. Certo, è diverso quando accade a te e non agli altri, nella realtà e non nella fantasia»[6]. Ma poi si accorge che «è impossibile vedere bene quando gli occhi sono offuscati dalle lacrime»[7], perché sperimenta che «meno la piango, mi sembra, più le sono vicino»[8]. Un altro scrittore, più recente e giovane, Alessandro D’Avenia, fa dire al protagonista – un professore cieco – del suo ultimo romanzo, in una sorta di continuità ideale:
Una lacrima è il modo in cui ammettiamo la nostra incapacità di trattenere la bellezza. L’amore arriva alla velocità della luce e l’occhio, vittima di questa bellezza, si inumidisce perché ha perso troppo presto ciò che non è stato capace di trattenere. E se si dice che nella vita eterna sarà asciugata ogni lacrima è solo perché, finalmente, i nostri occhi saranno della consistenza della luce stessa e quindi in grado di ricevere tutta la bellezza senza più perderla, tutto l’amore senza più perderlo, tutta la luce senza più perderla.[9]
Latina, 1° luglio 2021
[1] Cit. in G. Cucci, La morte. Cifra dell’esistere, Apostolato della preghiera, Roma 2017, 28.
[2] C.S. Lewis, Diario di un dolore [1961], Adelphi, Milano 1990, 45.
[3] Ib., 28-29.
[4] Ib., 77.
[5] A. Grün, Vivere il lutto significa amare. Vivere le nostre relazioni al di là della morte, Queriniana, Brescia 20192, 41.
[6] C.S. Lewis, cit., 44.
[7] Ib., 53-54.
[8] Ib., 65.
[9] A. D’Avenia, L’appello, Mondadori, Milano 2021, 209.