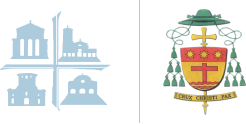OMELIA
Anniversario della dedicazione della cattedrale (1Re 8; 1Cor 3; Gv 2,13-22)
Latina, S. Marco, 18 dicembre 2020
+ Mariano Crociata
La festa di quest’anno non può non risentire del clima indotto dal prolungarsi della pandemia, dalle restrizioni ulteriori che si profilano per le festività e dalle incertezze per il futuro che neanche l’annuncio dell’imminente vaccino riesce a dissipare. In tale contesto, che cosa dice la festa di oggi a noi comunità ecclesiale? E che cosa dice alla comunità cittadina tutta, della quale la Chiesa si sente parte integrante e attiva, desiderosa di concorrere al bene dell’intera collettività?
Come credenti cerchiamo nel senso della festa della dedicazione e nelle pagine della Scrittura la luce per orientare il nostro cammino. Ciò che cogliamo è il valore dell’edificio sacro, punto di riferimento della Chiesa diocesana, come segno della sua unità e identità e come luogo di preghiera. Salomone supplica e invoca: «Ascolta e perdona», due parole nelle quali si racchiudono le invocazioni del credente, che ha bisogno di aiuto e di perdono. Al significato decisivo del tempio per la preghiera fanno riferimento il gesto e le parole di Gesù. E san Paolo sviluppa tale significato richiamando la grave responsabilità di edificare «il tempio di Dio, che siete voi». Quando non si usa il tempio di pietra soprattutto per pregare, non si edifica nemmeno il tempio che siamo noi sull’unico fondamento che può dare ad esso stabilità e splendore, e cioè Gesù Cristo e il suo Spirito. Perciò ritrovare il senso della chiesa di muratura conduce a riscoprire la verità del nostro essere comunità di fede nel cuore della comunità civile.
Da qualcuno è stata posta la domanda su quale sia stata la presenza della Chiesa in questi mesi di pandemia. Non abbiamo bisogno di svolgere sondaggi per raccogliere opinioni al riguardo, poiché siamo tenuti innanzitutto a un giudizio di coscienza e di verità, e non a inseguire le sirene del consenso. E secondo verità dobbiamo riconoscere che è stata molto generosa e tempestiva l’azione della Caritas, sia al livello diocesano che nelle parrocchie. I bisogni e le richieste si sono moltiplicati; ma anche la generosità si è accresciuta. In secondo luogo, le parrocchie sono state molto diligenti nel continuare, come e quando è stato possibile, le attività pastorali e le celebrazioni, sempre garantendo l’osservanza di tutte le procedure di sicurezza. Anche il contatto e la comunicazione personale sono stati coltivati, così da fornire a tante famiglie e persone sole, insieme al sussidio assistenziale, un sostegno morale e spirituale, a volte più importante dei beni materiali quando è la paura a paralizzare e a creare smarrimento e malessere. Difficile dire quanto abbiamo saputo rispondere al terzo compito, molto legato al conforto morale e spirituale di cui dicevamo. Quale messaggio è passato attraverso la nostra presenza e la nostra parola? Quanto siamo riusciti a dare luce al senso di ciò che stiamo vivendo collettivamente attingendo alle risorse della fede e della Parola di Dio? Credo che già con lo stile della presenza abbiamo trasmesso calore e incoraggiamento; d’altra parte il messaggio della fede ha suoi percorsi che si intrecciano col cammino di tutta la Chiesa, a cominciare dalla guida fondamentale di papa Francesco, e si propagano nei mille rivoli degli incontri e delle esperienze, praticamente indiscernibili allo sguardo di un osservatore esterno. Ora, però, sappiamo che il nostro compito è solo agli inizi, e in questo spirito vorrei aggiungere qualche considerazione che riguarda i fedeli delle nostre parrocchie ma tocca allo stesso tempo l’intera comunità civile.
Ciò che non ci serve in questo momento è accodarci alla infinita chiacchiera che ci avvolge come una nuvola di polvere da non pochi mesi, per scagliarci contro o a favore di chi porta l’ultima responsabilità nella vita del Paese. Ciò di cui abbiamo bisogno è guardare a noi stessi con onestà, riconoscendo i nostri limiti e le nostre responsabilità, soprattutto esaminando il nostro atteggiamento di fondo. A me pare che accanto a quelli che soffrono per la perdita del lavoro o per la sua precarietà, dobbiamo considerare quelli che un lavoro continuano ad averlo. Su questo settore della nostra comunità deve appuntarsi la nostra attenzione, perché in larga misura dipenderà da esso il modo come affronteremo i prossimi mesi e se riusciremo a riprenderci quando sarà stata raggiunta la cosiddetta immunità di gregge.
Questo è un punto fondamentale, poiché smaschera un alibi che serpeggia tra tutti, dentro e fuori la comunità ecclesiale. Stiamo tranquilli con le sicurezze che abbiamo – quelli che le abbiamo –, e attendiamo che passi la bufera; poi si vedrà. E intanto diminuisce la qualità della vita sociale, della vita scolastica, della vita istituzionale. La tentazione del cosiddetto smart working è che tutti si lavori di meno; il rischio della didattica a distanza è che si studi di meno; il risultato del distanziamento fisico è che adempimenti amministrativi e burocratici, che servono per mandare avanti le attività di privati e pubblici organismi, vengano rimandati a sempre nuova data da destinarsi, e quindi tutto rallenti e alla fine si fermi, lasciando senza risposta e per tempi insopportabilmente lunghi esigenze di tipo economico, assistenziale, sanitario e sociale di ogni genere. Questo non fa che accrescere il malessere dei singoli e della collettività, accumulandosi con quello prodotto dai problemi di chi è malato e di chi ha perduto il lavoro.
La causa di tale specifica situazione va cercata nell’orientamento morale e spirituale delle persone, talora segnate dagli effetti psicologici di un clima sociale depresso, ma spesso affette da una assenza di motivazioni e da un individualismo di fondo che rasenta la asocialità. Non serve appellarsi alle istituzioni o scaricare tutte le responsabilità su storture che pure si possono di fatto riscontrare. Se non altro perché le istituzioni sono fatte di uomini e donne che con le loro scelte soltanto permettono ad esse di funzionare e di andare avanti. Se ci sono cose – e ce ne sono molte – che funzionano, è perché ci sono persone che si dedicano con diligenza e passione a svolgere il proprio compito.
Viene il tempo in cui solo una mobilitazione morale potrà consentire di affrontare una situazione difficile, come quella che attraversiamo e che ci dobbiamo preparare a fronteggiare quando sarà finita la fase critica della pandemia. E questa mobilitazione deve cominciare ora, non solo lavorando fin d’ora con impegno e serietà, ma progettando e preparando iniziative e intraprese in grado di superare le conseguenze economiche e sociali, ma anche morali e psicologiche, di questa lunga crisi.
È il momento per questa città ancora informe quanto a identità ideale e culturale – e per la quale forse bisognerebbe ripescare il pirandelliano ‘Uno, nessuno e centomila’ – di trovare qualche elemento di unità proprio a partire da questa drammatica situazione. Tutte le civiltà, piccole e grandi, sono rinate dalla forte reazione di fronte ad una crisi estrema. Tale è stato il secondo dopoguerra per l’Italia e per molti Paesi europei. Questa crisi dobbiamo trasformarla in opportunità. È il momento dell’unità. È il momento – per questa nostra città – di diventare comunità solidale. Chi ha responsabilità, private e pubbliche, deve stare attento che certi passaggi della vita collettiva ormai prossimi non abbiano l’effetto di accrescere le lacerazioni che già attraversano e feriscono il tessuto della società civile di questa città.
Come comunità cristiana sentiamo la responsabilità di tutto questo. Mi pare che la conclusione che dobbiamo trarre è che il nostro compito è imparare a coniugare preghiera e impegno sociale. Non sono più i tempi nei quali ci possiamo rifugiare in un culto consolatorio e disancorato dalla concreta vita comune, per pensare ad una religiosità intimistica che si aliena dalla storia di tutti. Ma sappiamo bene che non possiamo votarci a un impegno per la città che non sia alimentato e nutrito da una fede profonda e da una spiritualità viva e incarnata, sull’esempio di un uomo come Giorgio La Pira, che rimane un modello mirabile di sintesi tra preghiera e impegno sociale, e per lui anche politico. Dobbiamo sentire la sfida che, non gli altri, ma la nostra stessa fede ci lancia, di mostrare – senza esibizionismo – che c’è una coerenza di cui si può vivere – anzi, si deve vivere – nella città degli uomini, in questa città, da edificare con la operosità e la partecipazione di tutti.