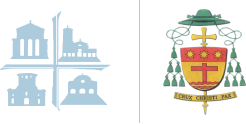OMELIA
Mercoledì 2 marzo 2016
III Settimana di Quaresima
Collegio Leoniano di Anagni
+ Mariano Crociata
Si riscontrano sempre profonde affinità tra il libro del Deuteronomio e il Vangelo di Matteo; le letture di oggi ne sono una eloquente testimonianza. Un motivo portante che accomuna le due sensibilità teologiche e spirituali è costituito dal tema dell’osservanza, del mettere in pratica la Parola di Dio e la sua legge. In particolare per il Deuteronomio c’è una stretta consequenzialità tra ascoltare, mettere in pratica e vivere, che vengono così a formare un trinomio inscindibile. Lo sviluppo sottolinea da un lato che nell’osservare e mettere in pratica consistono saggezza e intelligenza, e dall’altro lato che vivere e abitare la terra sono inseparabili. Cogliamo in queste connessioni la forma, tipica della cultura biblica, di un pensiero integrale, che non dissocia ma coordina e integra le varie dimensioni della condizione umana nel suo rapporto con Dio. Perciò vediamo ancora collegate invocazione e vicinanza di Dio, non dimenticare e trasmettere alle nuove generazioni.
Non può sussistere un pensiero astratto dalla vita, una devozione priva di interiorità e di coerenza morale. Il Vangelo arricchisce questa prospettiva collocando l’unità tra osservare e insegnare a osservare nell’orizzonte del disegno di Dio, destinato a realizzarsi in ogni suo più minuto particolare. Per la signoria di Dio non cambia molto, che il credente osservi o meno la sua Parola, poiché la signoria di Dio comunque si compirà; ciò che cambia è il destino e il posto del credente nel Regno di Dio. Viene alla mente il commento di S. Agostino al Padre nostro nella Lettera a Proba: «Quando diciamo: Venga il tuo regno, il quale, volere o no, verrà senz’altro, noi eccitiamo il nostro desiderio verso quel regno, affinché venga per noi e meritiamo di regnare in esso. Quando diciamo: Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, noi gli domandiamo l’obbedienza, per adempiere la sua volontà, a quel modo che è adempiuta dai suoi angeli nel cielo». Noi abbiamo bisogno, dunque, di quella coerenza del pensiero, del cuore e della vita che solamente dà accesso al Regno di Dio.
Due compiti immani si schiudono dinanzi a noi: l’unificazione di noi stessi e l’integrità del ministero.
Il primo è il compito della vita, che consiste nell’adempiere nella pratica le convinzioni maturate, ma poi anche richiede la fatica di adeguare con il cuore ciò che la mente comprende e la pratica spesso ritarda ad eseguire. Il dramma spirituale del credente è la divisione interiore, il sentirsi tirato da parti opposte, strattonato e dilaniato da desideri non ancora ricondotti a unità, da abitudini inveterate che mordono il freno, da convinzioni che resistono malamente alla pressione di forze contrastanti che tendono a modificarle per adattarle e accomodarle a se stesse. L’unità della persona è la meta ultima di ogni cammino spirituale, ma sembra remota e inarrivabile e perfino impossibile, se non fosse per la grazia di Dio, invocare la quale è sempre la cosa da fare e in taluni casi l’unica cosa che resta fare. In questo senso, minimo o grande nel Regno di Dio si è a seconda dell’essere poco o molto, in parte o per intero, sottomessi e sottoposti alla sovranità amorevole e unificante di Dio.
Il secondo compito riguarda il ministero. Qui si insinua la minaccia di una seconda dissociazione, oltre quella che il ministro condivide con ogni credente in ordine al proprio cammino spirituale di unificazione personale dinanzi a Dio. Mi riferisco alla dissociazione tra fare e insegnare. Si può cogliere in questo una sorta di contaminazione perversa tra il primo e il secondo compito, che si verifica quando ci adattiamo a pensare come viviamo (visto che non riusciamo a comportarci coerentemente secondo ciò che pensiamo), e – cosa tremenda – insegniamo anche ad altri a sottostimare o accomodare il comandamento di Dio. Senza arrivare a tale estremo, il rischio più ricorrente è che finiamo con l’insegnare ciò che non viviamo, o ciò che almeno non ci sforziamo sinceramente di mettere in pratica.
A questo riguardo mi dovete consentire un’ultima considerazione, che nasce da una domanda: che cosa un ministro ordinato è chiamato di fatto a osservare e praticare? La domanda sorge dalla constatazione che tutto ciò che un ministro pratica e tratta ha carattere rituale e pastorale. Un ministro non ha un lavoro da eseguire, una famiglia da portare avanti, delle responsabilità sociali da assumere, se non in alcuni casi e sotto certi aspetti. Il suo lavoro è il sacro, la sua famiglia è una comunità alla quale indirizzare un insegnamento e per la quale e con la quale celebrare; la vita ordinaria è in qualche misura e per tanti versi sottratta all’ambito di esercizio del ministero pastorale. Ciò fa venir meno quella connessione in successione ordinata che il Vangelo ci ingiunge: «Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli». Come a dire che l’insegnamento comincia con la pratica.
So bene che la dedicazione esclusiva al ministero pastorale ha una radice neotestamentaria e una solidissima tradizione lungo tutta la storia cristiana, per quanto già san Paolo abbia suggerito percorsi e opzioni tutte sue. Ciò che, in ogni caso, dobbiamo scongiurare, è che il nostro fare si riduca all’insegnare, e il nostro essere al solo parlare e proclamare, se non peggio declamare. La nostra vita non può ridursi a una recita, a una rappresentazione o anche soltanto a un ruolo, ma deve parlare di per se stessa, per il nostro modo di essere, di agire e di relazionarci. Insomma non siamo stati bravi ministri perché abbiamo fatto una buona predica e celebrato bene una Messa – ciò che comunque va curato con assoluta diligenza – ma se, prima ancora e al di là della capacità più o meno eccellente di parlare e di celebrare, la nostra persona, il nostro modo di essere e di agire, di stare in relazione con gli altri, di assumere atteggiamenti e di prendere decisioni, avrà parlato e manifestato con l’eloquenza della persona e della vita la verità di Dio che siamo chiamati ad annunciare anche con le parole.