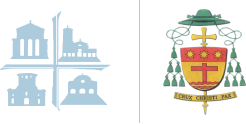OMELIA
Veglia di preghiera per Papa Francesco
Latina, cattedrale di san Marco, 23 aprile 2025
+ Mariano Crociata
Siamo rimasti tutti colpiti alla notizia della morte di papa Francesco, ma è straordinario vedere come lo siano state persone di ogni categoria e, perfino, appartenenza religiosa, oltre ogni confine geografico e culturale. È un segno inequivocabile che la sua persona ha raggiunto molte più persone di quelle che appartengono alla comunità ecclesiale cattolica e si capisce anche come figure della cultura e dal sentire molto laico dichiarino che con la sua morte è venuto meno un punto di riferimento importante per tutti e confessino di essere afferrati da un senso di vuoto.
Ritengo superfluo in questa veglia ripercorrere la sua vita e presentare la sua figura; penso invece che in un contesto di preghiera come questo siamo chiamati ad ascoltare il Signore sullo sfondo dell’insegnamento e della testimonianza di papa Francesco.
Prendo spunto da una precisa espressione che troviamo nel brano di vangelo appena proclamato, precisamente dal capitolo 21 di Giovanni. Gesù si rivolge a Pietro e gli dice: pasci i miei agnelli (una volta) e: pasci le mie pecore (due volte). È l’invito rivolto a Pietro, in quanto chiamato ad essere punto di riferimento dell’unità dei discepoli e modello del buon pastore, sull’esempio e a servizio di Gesù, unico supremo pastore. In Pietro c’è la figura originaria del ministero che oggi è quello del papa, ma insieme a lui tutti gli altri pastori, vescovi e presbiteri, e ancora tutti quelli che hanno responsabilità nei confronti degli altri, primi fra tutti i genitori, trovano motivo di misurarsi con questa parola di Gesù.
Che cosa significa pascere? Significa nutrire, aiutare a crescere, accudire e guidare. Quello che sono agnelli e pecore per uno dedito alla pastorizia, lo sono, fuor di metafora e di simbolismi, le persone, uomini e donne, che hanno scoperto e incontrato Gesù e che hanno deciso di seguirlo. Alcuni sono ancora fragili (agnelli), altri più forti (pecore), ma tutti hanno bisogno di essere aiutati e sostenuti. Ecco perché esiste il ministero nella Chiesa. Ecco perché esistono educatori e responsabili nei confronti degli altri, sia perché si rivolgono alla giovane età, sia in forza di una esperienza e di una competenza acquisite, che hanno il compito di pascere, cioè di guidare e aiutare a crescere e a camminare, un compito che con le opportune distinzioni può valere in qualche modo in tutti i nostri rapporti. Abbiamo tutti bisogno di aiutarci gli uni gli altri e a volte anche di guidarci.
Papa Francesco ci ha ricordato e insegnato in tante occasioni che cosa significhi pascere, nell’esercizio del ministero e in generale nell’ambito educativo e formativo. E la prima cosa che ha richiamato è il primato del vangelo: tornare ad esso e coltivarlo è il primo atto di ogni esistenza credente e servizio pastorale, perché il vangelo è via di vita e termine di confronto nella ricerca del senso autentico della vita e del giusto orientamento di ogni scelta e di ogni agire nella sequela di Gesù maestro e salvatore. Bisognerebbe chiedersi quanto il vangelo sia davvero questa luce perennemente accesa nella nostra mente e nel nostro cuore, o quanto invece sia ridotto a qualcosa di risaputo, magari citato a memoria ad ogni piè sospinto ma come un residuo culturale dato per scontato.
Di qui il secondo aspetto del pascere nella Chiesa, e cioè il discernimento. Di questo si è molto parlato, anche a proposito della sinodalità, in questi ultimi anni in particolare. Bisognerebbe riscoprire il senso genuino di un discernere che non è una tecnica né un semplice assecondare la prima intuizione che passa per la mente, ma è frutto di un lavorio interiore che insegna davvero ad ascoltare Dio che parla nel cuore e attraverso l’interiorità. Perché alla fine si tratta di imparare a vedere come stanno veramente le cose con noi stessi, e decidere ciò che è giusto secondo la volontà di bene di Dio.
Il fatto è che il cuore diventa sensibile alla conoscenza di Dio e della sua volontà di benevolenza e di amore via via che impara a passare tutto in rassegna (i pensieri e le emozioni, ma poi gli avvenimenti del grande e del piccolo mondo oltre quelli più strettamente personali) sulla base del vangelo e della parola di Dio e sulla base dell’attenzione alle ispirazioni con cui il Signore, che è Spirito Santo, lascia impregnare di sé la nostra interiorità quando respira un clima di attenzione, di raccoglimento e di preghiera. Insomma ascoltare il Signore e discernere non è qualcosa di superficiale e tanto meno di umorale o semplicemente intuitivo.
Non si può guidare nessuno se non si impara questo esercizio eminentemente interiore, che si manifesta poi in una condivisione – diciamo pure sinodale – che non è un semplice scambio di opinioni e una discussione o un confronto tra pareri diversi, ma la condivisione di una sensibilità allo Spirito che ciascuno ha sviluppato sempre di più. Questo genere di discernimento dovrebbe essere anche l’obiettivo educativo e formativo della fede di chi viene affidato alla nostra responsabilità di ministri ordinati o di educatori cristiani.
Ha un nesso molto stretto con tutto ciò che riguarda il discernimento, quello che è stato un motivo costante dell’impegno magisteriale e pastorale di papa Francesco, e cioè il dialogo. Il dialogo con tutti, dentro e fuori della Chiesa. La capacità di ascoltarsi e di ascoltare è una nota qualificante il servizio del pascere i fratelli. Il dialogo è reale, per noi credenti, quando muove dalla convinzione che il Signore agisce nel cuore degli altri come nel nostro. Certo, non in maniera automatica, poiché anche nell’ascolto bisogna esercitare un discernimento. Ma è sicuro che c’è un’azione dello Spirito in ciascuno, credente o non credente, così che è possibile raccogliere suggestioni che il Signore stesso ci vuole rivolgere attraverso l’altro, anche quello che sembra più lontano da Dio. Per noi credenti vale il dono dello Spirito nel battesimo che semina in tutti il senso soprannaturale della fede; ma il suo dono vale pure per ogni essere umano, nel quale il Signore misteriosamente opera, grazie alla Pasqua di Cristo, come insegna il concilio Vaticano II.
Un terzo aspetto della testimonianza del pascere secondo il comando di Gesù che ci viene da papa Francesco riguarda i poveri, e tra essi i migranti. Essi davvero sono un criterio per giudicare l’autenticità della fedeltà al vangelo e della maturità del discernimento e del dialogo. Il povero non è innanzitutto una categoria sociologica, ma una realtà teologica e spirituale. Il povero, in tutte le forme in cui si presenti, è colui con il quale Gesù stesso si identifica e perciò secondo cui vuole essere innanzitutto riconosciuto. E poi esso indica la realtà e la figura insieme dell’essere umano bisognoso e dunque della condizione umana in quanto indigente, che dipende e ha bisogno di altri per raggiungere e realizzare se stesso. Nel povero dunque ritroviamo le coordinate essenziali della nostra umanità. Imparare l’attenzione al bisognoso e la sensibilità ad ogni forma di dolore è il modo concreto per imparare a conoscere Gesù e a incontrare il fratello. Chi impara a incontrare e a entrare in empatia con chi è nel bisogno ha abbastanza umanità per incontrare tutti e aprirsi a tutti. Perché non c’è vero pascere senza aprirsi agli altri rompendo il guscio dell’egoismo e del narcisismo che ci tiene prigionieri.
C’è molto altro nel magistero di parole e di gesti di papa Francesco, ma è certo che gli elementi segnalati hanno un valore determinante; ad essi vogliamo ispirarci, in questo momento di preghiera di suffragio per lui; ma oltre questa fase di dolore e di distacco ad essi vogliamo guardare per tornare sempre di nuovo alle radici della nostra fede, aprendoci al futuro di Dio, che è insieme la sua promessa rivolta a noi e la nostra speranza. Quella speranza che significativamente papa Francesco ha voluto che connotasse questo anno giubilare.