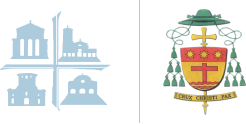Nell’ambito della programmazione offerta dalla Commissione diocesana per il Giubileo, in vista del Pellegrinaggio giubilare diocesano a Roma (27 settembre), lunedì scorso 15 settembre, presso l’abbazia di Fossanova, si è tenuta la preghiera dei Vespri, presieduti da S.E. Mons. Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento.
- L’abbazia di Fossanova
- I celebranti del Vespro: mons. Crociata e mons. Accrocca
- La Polifonica Pontina
Al termine della preghiera è seguito un concerto della Polifonica Pontina.

Mons. Felice Accrocca
Di seguito l’omelia pronunciata da mons. Felice Accrocca (che in basso si può scaricare anche come pdf):
Dalla Parola la Speranza
(Abbazia di Fossanova, 15 settembre 2025)
+ Felice Accrocca
Abramo «credette, saldo nella speranza contro ogni speranza». Le evidenze, e la ragione che da quelle consegue, lo spingevano ad assumere un orientamento realistico, ma egli, «di fronte alla promessa di Dio non esitò»; piuttosto, «si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio» fermamente convinto che Dio fosse capace di portare quella promessa a compimento. È la nostra fede che fonda la speranza; la fede, poi, nasce dall’ascolto (Rm 10,17), anzitutto della Parola di Dio.
Con impegno ancora maggiore, dunque, dobbiamo mettere al centro della nostra riflessione personale e comunitaria questa Parola: essa viene – come dice il Profeta – a «fasciare le piaghe dei cuori spezzati», a «consolare tutti gli afflitti», a darci «olio di letizia invece dell’abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto» (Is 61,1.2.3). E ne abbiamo bisogno! Stiamo assistendo, inerti, alla distruzione del diritto internazionale e di quello umanitario e abbiamo ragione di temere che alla forza del diritto si voglia sostituire il diritto della forza. Pur tuttavia, contro la tentazione della disperazione, il Qoèlet ci corregge con dolcezza, ma senza equivoci: «Non dire: “Come mai i tempi antichi erano migliori del presente?”, perché una domanda simile non è ispirata a saggezza» (7,10). Gli fa eco il grande Agostino: «”Sono tempi cattivi, tempi penosi!”, si dice. Ma cerchiamo di vivere bene e i tempi saranno buoni. I tempi siamo noi; come siamo noi così sono i tempi. […] il mondo lo rendono cattivo gli uomini cattivi» (Discorsi 80,8).
Di certo, viviamo in un tempo complesso, di difficile lettura. Il Signore ci ammonisce: «Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete valutarlo?» (Lc 12,56). Dobbiamo perciò esser capaci d’interpretare il presente alla luce della Parola di Dio. Profeta, dice Gregorio Magno, non è chi legge il futuro, bensì chi sa svelare il presente nascosto, il piano divino che in esso si cela (Omelie su Ezechiele I, 1); e Rabano Mauro ribadisce che uno degli aspetti qualificanti la profezia è svelare il senso profondo della Scrittura (Commento alla Prima lettera ai Corinzi XI, 12).
Per rinvigorire la speranza, dobbiamo perciò volgerci alla Parola di Dio, restituire ad essa la sua centralità nella vita della Chiesa. Nel commentare l’affermazione del Signore, il quale avrebbe ricondotto egli stesso le sue pecore sui monti d’Israele (Ez 24,13), Agostino esclama: «Egli [il Signore] ha formato i monti d’Israele, cioè gli autori delle Scritture divine. Lì andate a pascolare, se volete pascolare sicure. Ciò che udrete da quei monti formi il vostro gusto; ciò che vi viene da altre parti, respingetelo. Per non smarrirvi fra le nebbie, ascoltate la voce del pastore: raccoglietevi attorno ai monti che sono le sacre Scritture» (Discorsi 46,24). Meditandola, la Scrittura ci svelerà le sue ricchezze, crescerà con noi, poiché – assicura Gregorio – essa «cresce con coloro che la leggono» (Commento a Giobbe XX, 1) e coloro che la leggono crescono e maturano con essa nella fede, liberandola da inutili orpelli per tornare all’essenziale.
È necessario, però, assumere l’animo del Maestro, mite e umile di cuore (Mt 11,29), perché l’intelligenza della Scrittura si nasconde ai superbi e si svela agli umili. La Scrittura sacra, dice Agostino, «è fatta per crescere con i piccoli» (Confessioni III, 5, 9). E i piccoli, gli umili, sono capaci d’intenderne il significato profondo.
In un racconto riferito per primo da Tommaso da Celano – e che la storiografia più avvertita ha ritenuto degno di fede – si narra che si recò a far visita a san Francesco «un frate dell’Ordine dei predicatori, uomo spirituale e dottore in sacra teologia», che «lo interrogò su quel detto di Ezechiele: Se non manifesterai all’empio la sua empietà, domanderò conto a te della sua anima (Ez 3,18). […] E poiché Francesco si diceva ignorante e perciò degno più di essere da lui istruito, che di rispondere sopra una sentenza della Scrittura, il dottore aggiunse umilmente: “Fratello, anche se ho sentito alcuni dotti esporre questo passo, tuttavia volentieri gradirei a questo riguardo il tuo parere”. “Se la frase va presa in senso generico – rispose Francesco –, io la intendo così: Il servo di Dio deve avere in se stesso tale ardore di santità di vita, da rimproverare tutti gli empi con la luce dell’esempio e l’eloquenza della sua condotta. Così, ripeto, lo splendore della sua vita ed il buon odore della sua fama, renderanno manifesta a tutti la loro iniquità”. Quell’uomo «rimase molto edificato», per quella «interpretazione, e mentre se ne partiva, disse ai compagni di Francesco: “Fratelli miei, la teologia di questo uomo, sorretta dalla purezza e dalla contemplazione, vola come aquila. La nostra scienza invece striscia terra terra”» (2Cel 103: FF 690).
La Parola di Dio, che i piccoli sanno penetrare in profondità, ha un valore performante, opera una trasformazione in coloro che l’ascoltano. È questa Parola che ha plasmato il cuore dell’Apostolo, fino a fargli dire: «ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato». Sì, la speranza non delude e non illude: ci dà invece l’audacia dei visionari, di coloro, cioè, che hanno una visione, una mèta chiara; perché noi non andiamo verso il nulla, ma verso Qualcuno.
L’ascolto della Parola ci renda anche più disponibili all’ascolto reciproco, nella convinzione che «Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo» (Lumen Gentium 9).
La speranza che stasera condivido con voi è quella che – come comunità ecclesiale – restituiamo alla Parola il posto che le spetta nella nostra azione pastorale, perché solo questa Parola può fare di noi dei testimoni autentici della speranza cristiana. Sia davvero così.